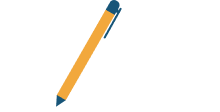Tortu: “In un mondo che corre troppo, ama quello che fai!”
Il campione olimpico di Tokyo 2020 nella staffetta 4x100, Filippo Tortu, ci racconta il suo rapporto con la vita e con la fede e apre insieme a noi l'album dei ricordi, dove c'è anche la fotografia del suo primo parroco a Costa Lambro (MB), don Cesare Minotti, scomparso a 81 anni nel 2019. "I valori della fede mi hanno insegnato ad essere una brava persona".
L’abbiamo ancora tutti negli occhi quell’immagine e ci rimarrà per sempre: Filippo che si mette le mani nei capelli e poi scoppia a piangere, incredulo. Era il 6 agosto 2021. Insieme a Lorenzo Patta, Marcel Jacobs e Fausto Desalu (i primi tre, in ordine di frazione) ha appena scritto la storia dell’atletica italiana laureandosi campione olimpico, a Tokyo. 37″ 50 il tempo della staffetta azzurra, con un’ultima frazione di Tortu letteralmente spaventosa.
Cosa ricordi con più emozione, Filippo: questa vittoria di squadra oppure quando a Madrid, il 22 giugno 2018, hai battuto lo storico record italiano dei 100 metri, 39 anni dopo il mito di Pietro Mennea, abbattendo il muro dei 10 secondi con 9″ 99?
Sono due ricordi diversi che mi stimolano emozioni differenti. Da un lato c’era l’obiettivo di battere Mennea, il mostro sacro a cui ogni velocista aspirava, dall’altra c’era il sogno di ogni sportivo del pianeta, vincere la medaglia d’oro alle olimpiadi. Forse la risposta sta nel fatto che la differenza fondamentale tra i due è che, pur avendo lavorato con tutte le energie che avevo per realizzarli, il primo ero certo che prima o poi l’avrei raggiunto, il secondo non avevo mai pensato nemmeno lontanamente di poterlo ottenere. Se per entrambi c’è stata una gioia straripante per molti giorni a venire, dopo il 9”99 ho pensato a “finalmente ce l’ho fatta”; dopo Tokyo ho pensato “non è possibile che sia successo”…
La tua specialità, la velocità, ti costringe a un esercizio psicologico incredibile. In una manciata di secondi si giocano la fatica, i sacrifici, il sudore di anni di lavoro: dal colpo di pistola dello starter alla linea del traguardo, senza appello. Bisogna avere una padronanza di sé che per un ragazzo non è normale. Come si fa a gestire una tensione simile? Qual è il segreto?
Non c’è un segreto vero e proprio. Alla fine, crescendo e facendo sempre la stessa cosa, ti abitui anche a situazioni estremamente complesse. Il fatto che non ci sia appello è la cosa che mi piace di questo sport perché implica un impegno psicologico disumano. La tensione è gestibile perché la butti tutta fuori con lo sforzo fisico appena lo starter spara: è come la valvola di sfogo.
Come coltivi la tua dimensione interiore, e che rapporto hai con la fede?
Lo sport individuale ti obbliga a fare i conti prima di tutto con te stesso e questo comporta un lavoro introspettivo molto importante. Se non riesci a pensare, a rapportarti con la tua coscienza in modo costruttivo, questo sport non lo puoi fare ad alto livello e devo dire che essere onesti con sé stessi è un passo fondamentale per essere non solo un buono sportivo ma anche una buona persona. Questo mi porta al rapporto con la fede, sulla quale ora come ora non sarei in grado di dare una risposta piena. La cosa però che considero preziosa è quello che ti insegna il percorso della fede cristiana che fai da bambino.
Il rispetto degli altri, il sacrificio per gli altri, il bene che deve essere anteposto al male, l’avere un atteggiamento critico ma costruttivo nei propri confronti.
Sono tutti valori che ti insegnano ad essere una brava persona, credo sia stato questo, per me, il grande valore della fede fino ad ora.
Andando a festeggiare la medaglia di Tokyo nella tua Brianza, a Costa Lambro, hai raccontato tu stesso di portare con te un’immaginetta del tuo vecchio parroco, don Cesare Minotti, che è mancato il 20 dicembre del 2019, a 81 anni. Vuoi regalarci qualche ricordo di lui e di quei tempi?
Don Cesare è sempre stato il punto di riferimento della nostra piccola cittadina. Ho dei ricordi molto semplici di lui, di come ci faceva giocare a calcio in oratorio, di come
ci insegnava a stare insieme, a rispettarci e a capirci tra noi.
Era una persona amorevole ed è sempre stato un simbolo di bontà per me.
Il tuo allenatore è papà Salvino, che per te in qualche modo è stato “doppiamente educatore”. Che rapporto hai con lui e quanto è stata importante la tua famiglia nel tuo percorso umano e sportivo?
Mio padre è stato la mia più grande fortuna da atleta. Mi ha cresciuto da bambino e poi mi ha guidato, e mi guida ancora, da atleta. È sicuramente stato il più grande fautore dei miei risultati e gli riconosco il grande pregio di non aver mai mescolato il ruolo di padre con il ruolo di allenatore, il che ha facilitato il mio percorso. Nel dargli un giudizio, non mi piace fare per forza un distinguo tra un grande allenatore e un grande padre. Mio padre è, molto più semplicemente, un grande uomo.
Hai 25 anni, Filippo: sei molto giovane ma certamente non sei più un ragazzo. Cosa ti senti di dire alle nuove generazioni che stai vedendo crescere: in che modo si può trasformare la propria esistenza in un capolavoro?
Sto vedendo che nella società di oggi c’è una forma malsana di competizione, non ci si sente mai abbastanza nei confronti della società. Forse la cosa più importante che mi sento di dire è che bisogna prima di tutto bisogna avere il rispetto di sé stessi. Nel senso che, se ami quello che fai, se sei bravo in quello che fai e se ti rende felice… chi se ne frega se non rispetta i canoni di una società che corre sempre troppo forte. Bisogna essere felici, facendo ciò che si ama. In questo modo è abbastanza naturale trasformare la propria esistenza in un capolavoro. Lo può fare chiunque: che sia effettivamente un capolavoro lo dobbiamo decidere solo noi.
(intervista di Stefano Proietti)