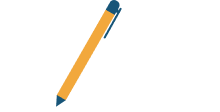La pazienza dell’ascolto… e riaffiora l’umanità insabbiata
Don Maurizio e don Pietro sono diventati sacerdoti lo stesso giorno, il 23 novembre di 26 anni fa. Ma c'è un'altra profondissima esperienza di vita che li accomuna: quella del servizio pastorale ai detenuti del carcere di Vibo Valentia. Sono le braccia tese di una comunità diocesana che non dimentica gli ultimi.
È tra i pochi in Calabria a non patire il sovraffollamento, nonostante il clima di tensione generale delle carceri italiane, le sofferenze dell’area sanitaria, la mancanza di manutenzione degli spazi detentivi e degli edifici, che rendono difficile ovunque la convivenza quotidiana. Stiamo parlando del complesso carcerario di Vibo Valentia, inaugurato nel 1997, con una capienza pari a 406 detenuti, e che al 31 maggio 2023 accoglieva 396 presenze (fonte: DAP).
Qui a prestare servizio come cappellani sono due sacerdoti della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, ordinati lo stesso giorno (il 23 novembre del 1996): don Maurizio Macrì, parroco di San Gregorio – San Gregorio d’Ippona e don Pietro Pontoriero, vice parroco nella Cattedrale di Mileto, in un territorio ad alto tasso di criminalità favorito dalla mancanza di occupazione.
“Sono cappellano da 13 anni – racconta don Maurizio, classe 1972 – nella Casa Circondariale di Vibo, dove sono detenute persone in attesa di giudizio, o con residui di pena inferiori ai 5 anni. Per intenderci: è un Istituto di custodia cautelare, diverso dalla Case di Reclusione o Istituti per l’esecuzione delle pene, ossia per le condanne definitive. L’età media dei detenuti qui è molto bassa, sono poco più che maggiorenni, campani in maggioranza, accusati di traffico di stupefacenti o associazione di stampo mafioso. Sette le sezioni complessive, tra alta e media sicurezza, nuovi giunti/transito, protetti promiscui, che è anche isolamento sanitario, e detenuti per reati sessuali”.
“Il mio primo ingresso in carcere – prosegue don Maurizio – risale al 2007 con Natuzza Evolo, la mistica e veggente di Paravati frazione di Mileto, morta nel 2009 a 86 anni, e di cui è in corso il processo di beatificazione. Allora ero viceparroco a Paravati e lei m’invitò ad accompagnarla in carcere. Mi rimase impresso che ci tenesse a incontrare tutti i detenuti singolarmente, parlando con ciascuno di loro. E così fece. La stessa Natuzza mi esortò ad accettare poi l’incarico di cappellano. A contatto con i detenuti, con situazioni di sofferenza familiare e disagio personale, ho riscoperto la bellezza dell’essere umano, dell’altro da noi; ho superato lo stigma, ho trovato valori che anche chi si è macchiato di una colpa può trasmettere, come la pazienza. Vivendo in un contesto di libertà noi spesso pretendiamo tutto e subito: invece per i detenuti il senso dell’attesa, la speranza, la fiducia, sono talvolta l’unica ancora di salvezza”.
“E capita pure di assistere ad alcune conversioni perché dedichiamo loro tanto ascolto (e non basta mai!), celebriamo Messa, finché arrivano a fidarsi di noi anche nel sacramento della riconciliazione. Un detenuto tempo fa mi ha detto: mi affido solo a Dio, non alla sentenza, che ormai è in Cassazione. Il desiderio d’incontrare Dio li spinge a chiederci di celebrare l’Eucarestia anche quando alcuni frangenti non ce lo consentirebbero. Il mese scorso, come Ufficio di Pastorale Penitenziaria, abbiamo vissuto la tappa del pellegrinaggio della Croce della Misericordia con le famiglie dei detenuti e tutto il clero diocesano, con tutti gli 11 cappellani delle carceri calabresi, e una sosta nel santuario di Paravati dedicato a Natuzza Evolo”.
Alla domanda su quale sia la cosa peggiore che ha visto in carcere, don Maurizio risponde: “Il pregiudizio su tutto ciò che gravita intorno al pianeta carcere, dentro e fuori.
E se ci fossi io al posto loro? Rifletto. Se mi fossi trovato io nel posto sbagliato?
Cambia la prospettiva di chi emette giudizi: anche una parola può essere intercettata e finisci in un circuito viziato. Cito sempre l’immagine dell’indice puntato: in realtà le altre quattro dita sono rivolte verso noi stessi”.
Il lavoro è tra i grandi assenti dall’istituto penitenziario vibonese. Le poche attività sono saltuarie (un’azienda locale molto nota, nel periodo natalizio, impiega alcuni detenuti nel confezionamento di ceste) o coinvolgono un numero trascurabile di persone detenute (solo 2 nella produzione di infissi in alluminio alle dipendenze di una ditta esterna; i rimanenti sono destinati alle attività dell’istituto). Ma lo sforzo anche della Caritas diocesana è di investire nella formazione professionale in carcere. Tra le attività il corso per il conseguimento dell’attestazione HACCP, un corso di rosticceria e uno per l’acquisizione della qualifica di operatore per intonaco e gessatura. “Nel mese di giugno sono partiti due corsi – spiega il volontario Raffaele Cuppari, diacono permanente, responsabile dello sportello Caritas – uno di panificazione, l’altro di pasticceria, finanziati dalla Caritas diocesana di Mileto, per volere del vescovo Attilio Nostro, molto attento alla pastorale carceraria. Insegnando religione nella casa circondariale – confessa Raffaele – quello che mi ha sconcertato è la malattia spirituale di cui soffrono i detenuti. A noi operatori Caritas più della distribuzione dei viveri (il pacco alimentare, che comprende anche vestiario) sta a cuore elargire dignità. La presenza dei volontari è sempre silenziosa e si nutre di rispetto reciproco, specie nei confronti delle donne, soprattutto mamme, catechiste, o docenti in pensione. Abbiamo portato a termine anche dei laboratori di falegnameria. Il Vescovo, nominato nell’ottobre 2022, nel giorno del suo insediamento ha ricevuto in dono da un detenuto una croce pettorale in legno, realizzata a mano. Abbiamo portato a termine anche corsi per pizzaioli, con attestati che ci auguriamo siano spendibili, poi, sul mercato del lavoro”.
“Le sbarre sono quelle che nascono dentro di noi – riprende don Maurizio -. Se non abbattiamo quelle barriere non riusciremo mai a comprendere il dolore che si solidifica nelle famiglie e nel tessuto sociale coinvolto. Attesissimo è il tradizionale appuntamento tra genitori detenuti e figli, attraverso l’attività sportiva nei campi di calcio: è la nostra partita del cuore, diventata un rituale irrinunciabile, tripudio di sentimenti positivi”.
Spaccati del carcere come questo hanno fatto cambiare idea a don Pietro Pontoriero, classe 1970, rimasto sconcertato dal suo primo impatto col carcere per sostituire don Maurizio. “Mai più”, aveva esclamato. “Due anni fa invece – ci spiega – mi si è ripresentata l’occasione: una dura prova per la mia vocazione ma, dopo aver partecipato al corso per cappellani, ho finito per accettare l’incarico del Vescovo”.
“È molto importante capire il linguaggio del carcere – continua don Pietro – perché incorrere in errori di valutazione e di comunicazione è molto facile. Essere cappellani in carcere non equivale allo stesso incarico in ospedale. Il rischio è di essere troppo accondiscendenti e grazie all’équipe specializzata, in particolare agli psicologi, sono riuscito a comprendere il giusto approccio. Nei primi tempi ero dominato dalla paura, perché di carattere sono piuttosto ansioso. È il detenuto che deve aprirsi al cappellano, non si può forzare e invadere un campo minato. Quando si raggiunge una fiducia cristallina il pianto liberatorio segna lo spartiacque nella relazione. Lacrime preziose agli occhi di Dio.
L’umanità insabbiata riaffiora, la corteccia s’incrina.
E dopo aver dialogato con loro, specie nelle sezioni isolate, torni all’aperto come la persona più libera del mondo, con una carica emotiva senza precedenti, sebbene sfiancato dalla fatica dell’ascolto. E tra di loro, poi, trovi qualcuno che sussurra: ti voglio bene. E scatta l’abbraccio, tanto forte da fare male. Ai detenuti, che hanno la coroncina di Cristo al collo, per libera scelta, non sfugge nulla: se vai di fretta, se hai disponibilità d’animo, sono loro che ti fanno la catechesi quando aprono il cuore e vedi dipanarsi la loro storia. Storie che spesso sono di solitudine personale e familiare, col dramma nel dramma della interruzione nei rapporti.
“Non potrò mai dimenticare – aggiunge don Maurizio – quando un detenuto venne a salutarmi con molta insistenza. L’indomani si è impiccato. Aveva 27 anni. Ero stato l’ultimo a cui aveva rivolto uno sguardo affettuoso. Mi è toccato avvisare la famiglia, la giovane moglie, la madre, la figlia. Non abbiamo mai perso i contatti da allora, la nostra diocesi li ha accolti e ospitati grazie a don Mimmo Dicarlo. Ancora questo trait d’union è vivo e sono certo che non si perderà”.
“L’aria qui è pesante, irrespirabile – concludono insieme don Maurizio e don Pietro – ma rivolgendoci al clero e alle istituzioni vogliamo lanciare un appello: cerchiamo di seminare rinascita e riscatto in queste vite infrante perché possano non tornare a delinquere fuori dalle celle”.
(di Sabina Leonetti – foto gentilmente concesse da don Maurizio Macrì e don Pietro Pontoriero)